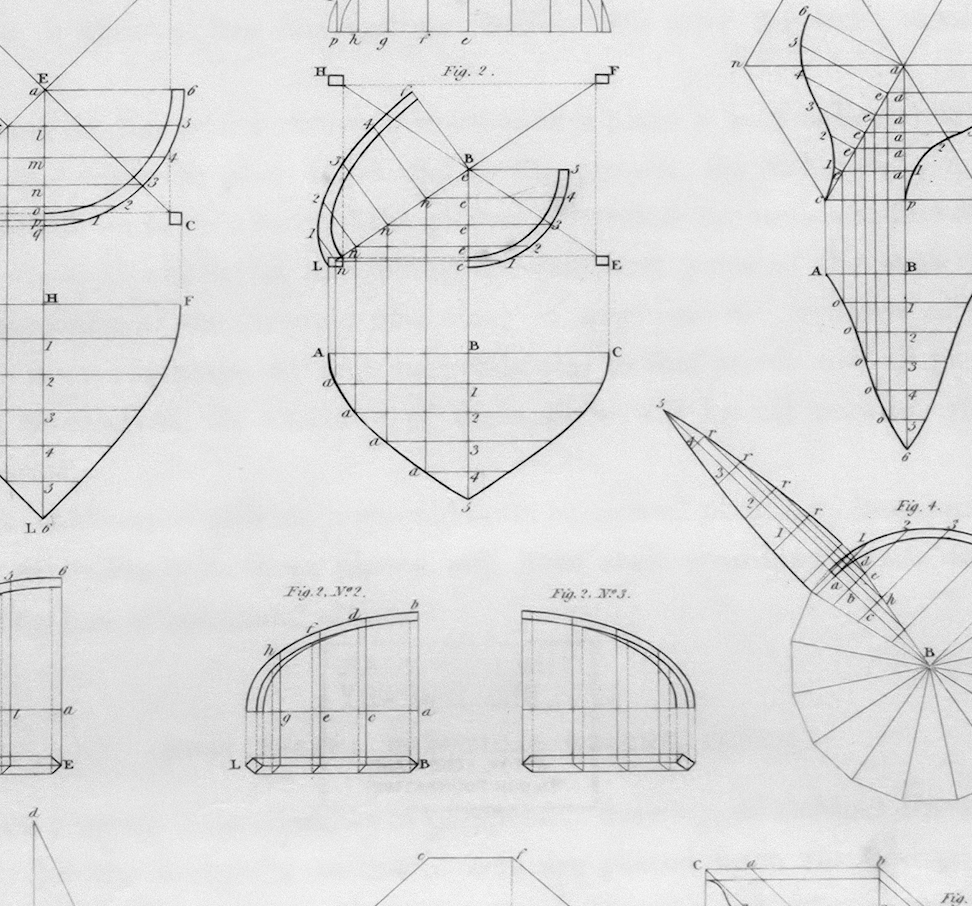Quando si parla di innovazione, idee e creatività tecnica, il primo concetto giuridico che viene in mente è il brevetto. Ma in concreto, che cos’è un brevetto? A cosa serve davvero? E soprattutto: chi ne ha bisogno?
In termini semplici, il brevetto è un titolo giuridico che attribuisce al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento di un’invenzione per un periodo limitato nel tempo. In altre parole, chi ottiene un brevetto ha il diritto di impedire ad altri di produrre, usare, vendere o importare quella specifica invenzione senza il suo consenso.
In Italia, la materia è disciplinata dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005) e il deposito si effettua presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), oppure — in alcuni casi — direttamente a livello europeo o internazionale.
Le tipologie di brevetto: non esiste solo l’invenzione
Quando si parla di brevetto, si pensa subito al classico esempio dell’invenzione industriale. Ma in realtà, la legge italiana riconosce due tipi principali di brevetto:
- Brevetto per invenzione: protegge una soluzione nuova e originale a un problema tecnico, che può essere applicata in campo industriale (es. un nuovo dispositivo, una macchina, un sistema meccanico).
- Brevetto per modello di utilità: riguarda modifiche innovative a oggetti già esistenti che migliorano l'efficienza, l'utilizzo o la praticità di un prodotto, pur non costituendo un’invenzione in senso stretto.
A questi si aggiungono altre forme di protezione, come i disegni e modelli (per l’estetica di un prodotto) e il diritto d’autore (per software, testi, ecc.), che spesso si intrecciano con la materia brevettuale.
I requisiti essenziali per brevettare
Affinché una creazione possa essere brevettata, deve rispondere ad alcuni requisiti fondamentali:
- Novità: non deve essere già stata resa nota, nemmeno dallo stesso inventore.
- Attività inventiva: deve trattarsi di qualcosa che non sia ovvio per un tecnico del settore.
- Industrialità: deve essere concretamente realizzabile in ambito industriale o tecnico.
Non sono brevettabili, ad esempio, le idee astratte, le teorie scientifiche, i metodi commerciali, i programmi per elaboratore in quanto tali, o le scoperte della natura. Serve sempre un'applicazione tecnica concreta.
Tempistiche e durata della protezione brevettuale
Una volta presentata la domanda di brevetto, il richiedente ottiene una tutela potenziale sull’invenzione, che – se concessa – potrà durare fino a 20 anni dalla data di deposito. La procedura di esame prevede diverse tappe e può variare a seconda del tipo di brevetto e dell’ambito territoriale scelto.
Nei primi 12 mesi dalla data di deposito (il cosiddetto anno di priorità), il titolare ha la possibilità di estendere la domanda ad altri Paesi, mantenendo come riferimento la data iniziale, secondo le regole internazionali (Convenzione di Parigi).
Nel caso di domanda italiana, l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) si occupa di redigere il rapporto di ricerca entro circa 9 mesi: un documento tecnico che serve a valutare se l’invenzione soddisfa i requisiti di novità e attività inventiva.
Trascorsi 18 mesi, la domanda viene pubblicata e diventa consultabile anche da terzi. Da quel momento, chiunque può prenderne visione e – se del caso – sollevare osservazioni o opposizioni, soprattutto in ambito europeo o internazionale.
Infine, tra i 24 e i 36 mesi successivi al deposito, l’Ufficio competente comunicherà la concessione o il rigetto del brevetto. In caso di rifiuto, l’interessato ha 60 giorni di tempo per impugnare la decisione, chiedendone la revisione secondo le modalità previste.
E per i modelli di utilità?
Il modello di utilità ha una procedura generalmente più snella e una durata più breve. La protezione ha una validità di 10 anni dalla data di deposito, senza possibilità di rinnovo. Non è previsto, nella procedura italiana, un rapporto di ricerca formale come per il brevetto per invenzione industriale, e i tempi di concessione sono spesso più rapidi, salvo richiesta di esame approfondito.
Anche il modello di utilità può essere esteso all’estero, ma con alcune limitazioni: molti ordinamenti, infatti, non prevedono questa forma di tutela o la trattano in modo assimilato al brevetto ordinario. È quindi fondamentale valutare caso per caso la strategia migliore di protezione, specie se si intende operare su mercati esteri.
Perché è importante registrare un brevetto (e cosa succede se non lo fai)
Registrare un brevetto non è una formalità, ma una strategia di protezione vera e propria. Senza brevetto, l’invenzione resta vulnerabile: chiunque può copiarla, sfruttarla o addirittura registrarla a proprio nome.
In materia vale il principio del "first to file": non conta chi ha avuto per primo l’idea, ma chi ha depositato il brevetto per primo. E chi detiene un brevetto può vietare l’uso dell’invenzione a terzi, chiedere la distruzione dei prodotti contraffatti e persino ottenere un risarcimento per lo sfruttamento non autorizzato.
Chi utilizza senza permesso un’invenzione brevettata, infatti, rischia responsabilità civile e, in alcuni casi, anche penale.
Conclusioni
Il brevetto è molto più di un timbro o di un certificato simbolico: è uno scudo giuridico che protegge l’innovazione, consente di valorizzarla economicamente e di difendersi da concorrenza sleale, copie e appropriazioni indebite. Se hai ideato qualcosa di nuovo, il primo passo è sempre lo stesso: verifica se puoi brevettarlo. Il secondo è agire, prima che lo faccia qualcun altro.
📩 Per una consulenza in materia puoi scrivermi a: avvocatodaviderocchi@gmail.com
📍 Ricevo su appuntamento online e di persona presso lo studio in Roma.